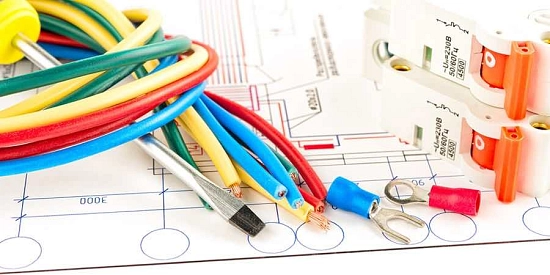Dopo aver parlato del contratto di locazione a canone agevolato e dell'affitto a canone libero, in questo articolo parleremo del caso in cui avvenga la risoluzione anticipata di un contratto di locazione, per il quale si è pagata l’imposta di registro per l’intera sua durata, il contribuente ha diritto al rimborso della parte di imposta relativa alle annualità successive a quella nel corso della quale si è verificata la risoluzione.
Menu di navigazione dell'articolo
- Chi può chiedere la risoluzione anticipata del contratto di locazione?
- Rimborso dell'Imposta di Registro in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione?
- Come effettuarla
- Quando può essere richiesta la risoluzione
- Accertamento oggettivo e criterio soggettivo
- Come si difende il proprietario?
- Spese di registrazione dei contratti di affitto e locazione: le informazioni utili
- Versamento unico delle spese per i contratti pluriennali
- La registrazione telematica del contratto
- Durata dei contratti di locazioni transitorie
- Rinnovo della locazione transitoria
- Locazione a Roma
- Cessazione del contratto di locazione, quando e come
- FAQ
Chi può chiedere la risoluzione anticipata del contratto di locazione?
La legge stabilisce che solo il conduttore, ovvero l'inquilino, può recedere dal contratto d'affitto, mentre tale possibilità non è concessa al Locatore, cioè colui che affitta l'immobile. Questa disposizione ha sollevato dubbi sulla sua costituzionalità, ma la Corte Costituzionale ha respinto tali dubbi, sostenendo che è appropriato offrire maggiori tutele alla parte più debole del contratto, ovvero gli inquilini.
La possibilità di recedere dal contratto d'affitto da parte dell'inquilino è prevista sia per locali adibiti a uso commerciale sia per quelli ad uso privato, abitativo o di natura transitoria. In sostanza, la legge intende proteggere gli inquilini, considerati la parte più vulnerabile nel rapporto di locazione, garantendo loro la possibilità di recedere dal contratto d'affitto in determinate circostanze, mentre il locatore non gode della stessa facoltà.
A tal proposito quindi è importante controllare la natura del contratto e soprattutto la sua durata che a seconda della tipologia riserva diverse formule (per quelle commerciali si parla della formula 6+6). La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata andata/ritorno rispettando le tempistiche vigenti, ossia con sei mesi di anticipo rispetto alla data scelta per lasciare l’immobile. Nelle carte andrà precisato anche il motivo per il quale si decide di lasciare in anticipo l’immobile affittato in precedenza. Nella lettera da inviare, dovranno comparire anche i dati anagrafici del richiedente, richiesta e tempistiche riguardo il recesso in anticipo del contratto di locazione.
A tal proposito, il conduttore è obbligato a pagare anche la parte restante d’affitto fino alla data scelta di addio all’immobile. Tuttavia, se il proprietario riuscirà ad affittare l’immobile ad altri soggetti, si dovrà pagare il recesso anticipato per il periodo che l’immobile in questione è rimasto sfitto, ossia inabitato o non usufruito prima della scadenza originariamente prevista.
Bisogna infine aggiungere che il recesso non può avvenire per qualsiasi motivo visto che ciò può accadere solo in taluni casi espressi dalla legge, definiti “gravi motivi”, classificabili in: estranei alla volontà dell’inquilino, imprevedibili od oggettivi.
Per capire meglio come l'imposta di bollo influisce sui contratti di locazione, ti consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato, ricco di informazioni utili e consigli pratici.
Rimborso dell'Imposta di Registro in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione?
Il rimborso dell'imposta di registro può essere richiesto entro tre anni dal giorno della risoluzione, presentando domanda all'ufficio delle Entrate che ha eseguito la registrazione della dichiarazione relativa al contratto (art 77 del Testo Unico delle Imposte di Registro n. 131 del 1986).
A chi spetta l'onere di versare la tassa?
L'onere di provvedere al versamento della tassa di risoluzione anticipata del contratto di locazione compete al locatore, salvo il rimborso della metà di quanto anticipato, a norma dell'articolo 8, legge 392/78.
Locatore e conduttore sono obbligati solidalmente al versamento della tassa, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera a), decreto del presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, numero 131. Infatti, molto spesso questa imposta viene suddivisa a metà tra le due parti in causa; in caso contrario sarà il locatario a dover saldare per intero questa tassa. Prima di ciò, è bene controllare se nel contratto di locazione ci sia una postilla in merito: in questo caso si seguirà cosa ci sarà scritto nel contratto.
Come effettuarla
La risoluzione anticipata del contratto di locazione può essere effettuato sia dal proprietario che dall’inquilino ma esistono diverse procedure e informazioni da sapere che cambiano da contratto a contratto. Per i contratti d’affitto ci sono due forme di rinnovo, il 4+4 e il 3+2; di solito il recesso avviene alla fine del secondo rinnovo ma in determinate condizioni il diniego può avvenire prima.
Queste condizioni sono per il proprietario:
- cambio uso dell’immobile per motivi professionali o commerciali
- utilizzo dell’immobile per sé o per la propria famiglia
e per l’inquilino:
- disponibilità di affittare un alloggio sempre nello stesso comune
- l’inquilino non alloggia in maniera continuativa nell’immobile affittato
Per la risoluzione anticipata del contratto di locazione, si deve inviare una lettera contenente la disdetta del contratto d’affitto a mezzo raccomandata A/R entro sei mesi se il contratto è del tipo 4+4 o tre mesi se il contratto in essere è di tipo transitorio. Il proprietario non può rompere il contratto se non rispettando le condizioni poste dalla legge mentre l’inquilino può fare la risoluzione anticipata del contratto di locazione in qualsiasi momento, qualora ricorrano gravi motivi. Questo avviene perchè il legislatore, nonostante i dubbi di costituzionalità avanzati dai locatari, ha preferito tutelare la parte debole nel contratto, ossia l’affittuario.
In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione, il proprietario è tenuto a pagare, tramite modello F23, l’imposta di registro per la disdetta anticipata del contratto. In questo caso, generalmente l’imposta viene divisa tra conduttore e locatario ma qualora ciò non si verificasse, sarà il proprietario a dover corrispondere tale somma all’Agenzia delle Entrate. Per i casi di uso foresteria, ossia appartamenti presi dalle società per far alloggiare un proprio dipendente, il recesso va comunicato entro la data stipulata nel contratto che di solito è fissata in tre mesi prima della scadeza. Da aggiungere che l’uso foresteria è ben diverso dalle altre tipologie contrattuali perchè prevede tre parti interessate nell’accordo: proprietario, azienda (che ha personalità giuridica) e personale che concretamente lavorerà presso il locale. L’uso foresteria inoltre permette una serie di agevolazioni fiscali sia per il conduttore che per il locatario.
Quando può essere richiesta la risoluzione
La risoluzione per inadempimento può essere richiesta anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non si verifica il contrario invece.
L'effetto giuridico legato a questo tipo di istituto è quello di sciogliere, con effetto retroattivo, il rapporto obbligatorio fra le parti contraenti. Il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni.
In sostanza, la risoluzione per inadempimento si verifica tutte le volte in cui l'onere che vincola il debitore non è stato da quest'ultimo effettuato.
È da sottolineare che una sentenza del giudice che stabilisca la validità della risoluzione ha effetto preclusivo: la parte in torto non può, dopo la decisione adempiere alla propria obbligazione.
Una volta accertato questo, è possibile per la parte lesa chiedere il risarcimento (l'“interesse positivo”). Questa domanda può essere proposta sia contestualmente alla risoluzione che in separata sede, visto che il risarcimento può seguire un iter del tutto svincolato dal primo istituto – ovvero, le due istante non sono legate.
Due diverse situazioni di inadempimento


Di particolare importanza è la differenza tra il ritardo nell'adempimento e l'inadempimento definitivo.
La stesura della domanda di risoluzione del contratto non possiede un'efficacia limitata alle sole parti contrattuali, ma può avere effetti anche nei confronti dei terzi.
La caparra è da restituire oppure no in caso di risoluzione?
La cosiddetta “caparra confirmatoria” è una somma di denaro che che viene conferita alla conclusione di un contratto. Ha solitamente il compito di rafforzare e legittimare il vincolo già espresso dal contratto.
Ecco come si comporta la caparra nei vari casi contrattuali:
- Entrambe le parti sono adempienti. In questo caso, la parte che ha ricevuto la caparra la può detrarre dal costo finale oppure restituirla a fine contratto (si pensi alle “mesate morte” relativo all'affitto di un appartamento.
- La parte che ha dato la caparra è inadempiente. In questo caso, l'altra parte può trattenere la caparra e recede dal contratto che, quindi, viene sciolto.
- La parte che ha ricevuto la caparra è inadempiente. L'altra può richiedere al giudice il doppio della somma conferita e recedere dal contratto. Come si è detto quando si è parlato di interesse positivo, quest'azione è completamente slegata dalla richiesta di risoluzione o adempimento.
Accertamento oggettivo e criterio soggettivo
Un ultimo elemento sul quale è doveroso soffermarsi nella trattazione di questo argomento è il rapporto fra l'accertamento oggettivo e il criterio soggettivo.
Per risolvere un contratto, occorre che il giudice attesti che l'inadempimento avvenuto non sia di scarsa importanza. L'accertamento oggettivo, quindi, è finalizzato a verificare la quantità oggettiva di danno che è stato cagionato a una delle parti. Tuttavia è ovvio che, a prescindere dalla possibilità di misurare o meno il danno, al giudice è concesso un criterio soggettivo per valutare tutto quello in cui una misurazione non è possibile.
Per questa ragione, il giudice è esortato ad uniformarsi al criterio di proporzione ovvero sulla “buona fede” contrattuale, ovvero sulla correttezza delle parti in sede di contratto.
Come si difende il proprietario?
Il locatario ha diversi strumenti per difendersi dalla rottura anticipata del contratto da parte del conduttore. Ecco quali sono: affidarsi ad agenzie immobiliari per la ricerca dell’inquilino (all’azienda che funge da intermediario andrà corrisposto una parcella variabile, circa del 10%); avere una polizza assicurativa per proteggersi da mancati pagamenti; risoluzione del contratto per morosità; per quanto riguarda la rottura anticipata, il conduttore è tenuto a pagare l’affitto fino alla data in cui lascerà l’immobile; nel caso di ritardi di pagamento, la legge prevede un periodo di venti giorni concessi all’inquilino per saldare le mensilità arretrate.
Recesso locazione, il rovescio della medaglia

La crisi economica che sta colpendo il mondo sta avendo forti ripercussioni anche in Italia sul campo dei canoni d’affitti degli esercizi commerciali. A Catania più del 25% dei negozianti ha chiesto la risoluzione anticipata del contratto di locazione, poichè sono strozzati da costi troppo alti, aumentati in alcuni casi anche del 37%. Gli stessi esercenti hanno chiesto un intervento degli Enti Locali per porre rimedio a una situazione che vedrà molte botteghe chiudere le saracinesche (si parla di un negozio su quattro in Via Etna).
Non è un caso quindi che la morosità in Italia sia aumentata enormemente (soprattutto la morosità incolpevole), tanto che la metà degli inquilini è in ritardo con l’affitto mensile da pagare. A riguardo, i proprietari possono scegliere diverse vie, come la trattazione o la negoziazione delle rate da pagare, il sollecito, l’ingiunzione fino ad arrivare alla decisione drastica, lo sfratto.
Sulla morosità incolpevole, il Governo ha stanziato un fondo per aiutare quei cittadini che non riescono a pagare l’affitto perchè sono stati licenziati o perchè per causa di forza maggiore non hanno più i soldi per saldare le mensilità pregresse. Inoltre, l’esecutivo Renzi ha varato delle misure per incentivare il mercato immobiliare, come per esempio la possibilità di concedere benefici fiscali (fino al 20%) a chi compra casa e l’affitta per un lasso di tempo uguale a otto anni a un canone concordato. Il Premier con questa misura cerca di far uscire dallo stagno questo settore che è rimasto impantanato negli ultimi anni dopo lo scoppio della crisi economica.
Come effettuare la risoluzione dell'accordo
La risoluzione anticipata del contratto di locazione può essere proposta sia dal locatore che dal conduttore, seppur con modalità e cause differenti. Di norma per proporla, sia nel caso del locatore che del conduttore, sono previsti almeno sei mesi di preavviso, e la proposta di risoluzione deve essere recapitata alla controparte in forma scritta, possibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; ma è rimessa alla volontà contrattuale delle parti prevedere tempistiche differenti che risultino dal contratto.
Risoluzione da parte del locatore
La risoluzione anticipata del contratto di locazione può essere proposta dal locatore al verificarsi di determinati eventi, tassativamente previsti dal contratto. In ogni tipologia di accordo che abbiamo firmato, sin dai tempi dell’Università, erano presenti delle clausole che prevedevano la possibilità da parte del locatore di proporre la risoluzione, o che prevedevano una risoluzione del contratto di locazione di diritto: tipico è il caso in cui il conduttore non paga nei tempi previsti nel contratto la quota mensile d’affitto, avvenimento che permette al locatore di proporre risoluzione di diritto del documento di locazione. Normalmente le formule di locazione prevedono contratti con rinnovo automatico, salva diversa volontà espressa dalle parti, è il caso dei contratti 3+2 o 4+4.
Qualora le parti non concordino sul rinnovo, non è necessaria la formalizzazione di una risoluzione del documento. Infine è fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore qualora intenda vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 3 L.431/98.
Risoluzione del conduttore
Al conduttore è riconosciuto un più semplice obbligo per la risoluzione del documento: avrà, infatti, facoltà di recedere per gravi motivi, inviando al locatore lettera raccomanda con ricevuta di ritorno con un anticipo di almeno sei mesi. Solo questa condizione deve essere soddisfatta.
Importante sottolineare che qualora il conduttore intenda proporre la risoluzione anticipata del contratto di locazione, le mensilità rimanenti dovranno essere interamente pagate, non sarà quindi possibile intaccare le caparre versate al momento della stipula del documento di locazione, poiché se si procedesse in questa direzione, la tutela economica di cui gode il locatore per gli eventuali danni recati all’immobile nel periodo, verrebbe meno.
Spese di registrazione dei contratti di affitto e locazione: le informazioni utili
Qualora abbia una durata superiore ai 30 giorni in un anno, la registrazione dei contratti d'affitto è obbligatoria. Vediamo quali sono le modalità per tale procedura e quali i costi.
Il costo per la registrazione del contratto di affitto è:
- L'imposta di registro non grava sul deposito cauzionale versato dall’inquilino.
La spesa inerente la registrazione del contratto di locazione, spetta al 50% al locatore e al locatario.
Versamento unico delle spese per i contratti pluriennali
Nel caso di contratti pluriennali, è possibile decidere di versare l'intero importo dovuto alla registrazione dei contratti di affitto in un'unica soluzione.
Normalmente, si dovrebbe pagare il 2% del corrispettivo complessivo oppure il 2% dell'importo di ogni anno (tenendo conto degli aumenti Istat). Tuttavia se, come si diceva, si procedere con il pagamento dell'importo di tutto il periodo preso in considerazione dal contratto, si può godere di uno sconto pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero di anni del contratto
Risoluzione anticipata del contratto di locazione da parte dell'inquilino
Se un inquilino disdice un contratto anticipatamente con risoluzione anticipata del contratto di locazione ed è stato versato l’importo relativo all’intera durata, chi ha pagato quindi ha diritto ad un rimborso totale deglianni successivi e quello in corso. In caso di locazione di immobili non urbani, l’imposta si applica (nella misura del 2%) all’importo dei canoni ancora dovuti.
Versamento delle imposte del contratto di affitto
Ancora prima di portare la registrazione dei contratti della locazione e affitto, i contraenti devono calcolare l’imposta necessaria e successivamente versarla presso un qualsiasi concessionario addetto alla riscossione, oppure una banca o un ufficio postale, utilizzando però il mod. F23.
La copia dell’attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto (per gli immobili urbani) all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione compilata sull’apposito stampato in distribuzione presso l’Ufficio.
La registrazione telematica del contratto
La legge n.44 del 26 aprile 2012 ha esteso l'obbligo di registrazione telematica a coloro in possesso di appena dieci unità immobiliari. Prima dell'entrata in vigore della legge, il limite era di 100. Il drastico calo è stato pensato come strumento utile a combattere il fenomeno degli affitti in nero, ma rischia di travolgere le migliaia di padroni di casa che hanno utilizzato per moltissimi anni il sistema cartaceo e oggi, complici sia l'abitudine che in alcuni casi l'età avanzata, si vedono costretti a rivolgersi a professionisti per una procedura che hanno sempre svolto da sé.
È possibile infatti rivolgersi a soggetti delegati dalla legge (al Caf, ai commercialisti, a periti).
Un'altra novità è che anche gli agenti di affari in mediazione sono tenuti a procedere col completamento della registrazione dei contratti di affitto per via telematica.
Questa avviene attraverso uno dei numerosi strumenti che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione.
Siria. Nella sua versione online oppure nella sua versione web, questo programma viene utilizzato per la registrazione di immobili ad uso abitativo e commerciale con opzione per la Cedolare secca.
Iris. Anche questo software vanta una versione da utilizzare in locale (nel proprio pc) e una via web. Viene utilizzato per la registrazione di immobili ad uso abitativo e commerciale quando contestualmente avviene il pagamento dell'imposta di registro e di bollo.
Entrambi i programmi possono essere utilizzati solo quando si registra un contratto relativo a massimo tre affittuari in un unico immobile (per altri immobili occorre avviare un'istanza separata) e i contraenti sono persone fisiche.
Contratti di locazione e Locazioni web sono gli ultimi due programmi della famiglia che vengono utilizzati in tutti gli altri casi.
Per chi è obbligatoria
Com’è già stato detto in precedenza la registrazione telematica dei contratti di locazione è obbligatoria per coloro che hanno la proprietà di almeno dieci immobili e per gli agenti immobiliari, ma può essere comunque utilizzata da chiunque preferisca questo mezzo per regolarizzare la situazione. Qualunque sistema si decida di utilizzare, al termine della registrazione richiederà all’interessato di inserire le coordinate bancarie del conto corrente sul quale saranno prelevate le tasse di registro e di bollo. E’ importante sapere che c’è una particolare tipologia di contratto, definita cedolare secca, che non prevede il pagamento di questo genere di imposte. Questa forma contrattuale è concessa solo ai beni immobiliari ad uso abitativo, che hanno un accatastamento A/1 e A/11, sono di conseguenza esclusi gli uffici.
Dal 3 Febbraio 2014 il tradizionale modello 69 è stato rimpiazzato dal modello RLI, che si può ottenere recandosi in un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. All’interno del suddetto modello vanno inseriti dei precisi dati, che sono riportati nell’elenco che segue.
- I dati personali del proprietario dell’immobile e del locatario.
- Le informazioni generali sul contratto, come la durata, la data ecc.
- Le informazioni dell’immobile in questione.
- La scelta della cedolare secca oppure la sua revoca.
Il documento correttamente compilato deve essere spedito in via telematica direttamente dall’interessato oppure tramite il commercialista. E’ importante allegare alla domanda di registrazione una fotocopia del contratto di locazione. Ci sono alcune specifiche situazioni per le quali è concesso un iter più semplice di registrazione e sono illustrate nell’elenco che segue.
- Beni immobili che sono stati censiti con attribuzione di rendita.
- Un’abitazione che abbia al massimo tre pertinenze e che sia di proprietà di persone fisiche che non hanno finalità legate all’esercizio di impresa, professione o arte. Non rientrano quindi in questa categoria le persone non giuridiche, ad esempio gli enti.
- Contratto che tratti solo il rapporto di locazione tra le parti interessate e non altre eventuali clausole.
E’ importante sapere che il modello RLI deve essere utilizzato dal locatore anche per tutti gli adempimenti che avvengono in data posteriore al contratto, ad esempio risoluzione anticipata del contratto di locazione, revoche, proroghe ecc.
Documenti necessari alla registrazione del contratto di locazione
La registrazione dei contratti di affitto secondo la procedura cartacea e tradizionale può essere effettuata in qualsiasi ufficio dell’Agenzia, avendo con sé:
- un originale e una fotocopia (o più originali) del contratto d'affitto da registrare;
- attestato di versamento (copia mod. F23 preso in Ufficio, compilato con il codice tributo correttamente indicato, e presentato in banca o alle poste per il pagamento).
Iter da seguire in caso di registrazione dei contratti di locazione di immobili urbani presso l'Agenzia delle Entrate
Quando: entro 30 giorni dalla data dell'atto (o dalla decorrenza, se anteriore) presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Compilare:
- il modello 69 (disponibile presso l'ufficio)
- la quietanza di pagamento dell'imposta (mod. F23)
Presentare:
- il contratto di locazione da registrare
- (almeno due copie) con firme in originale
- (su ogni copia del contratto va applicata, per ogni 4 facciate di 100 righe, una marca da bollo da14,62 euro)
Pagare: un importo pari al 2% del canone annuo, mediante presentazione del modello F23 presso gli agenti della riscossione, le banche o gli uffici postali.
L'ufficio rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione le copie registrate si ottengono nel tempo comunicato all'atto della consegna.
Iter da seguire in caso di registrazione dei contratti di locazione di fondi rustici

La registrazione dei contratti d'affitto di fondi rustici avviene presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel corso dell’anno precedente.
Durata dei contratti di locazioni transitorie
Per i proprietari, le condizioni previste per la locazione transitoria sono legate a:
- dover vendere l'abitazione in tempi brevi;
- dover destinare l'immobile ad abitazione o ad attività propria o dei familiari;
- dover eseguire in poco tempo lavori di edilizia;
- cause di natura legale legate a separazioni o divorzi.
I casi in cui l'inquilino opta per questo tipo di contratto

E' ammissibile quando:
- sono necessarie cure e/o assistenza per sé o per i propri familiari in un luogo diverso dalla propria residenza;
- possiede un contratto o un trasferimento di lavoro a carattere temporaneo;
- si devono effettuare lavori nella propria casa che la rendano temporaneamente inutilizzabile;
- è in attesa della disponibilità effettiva di un immobile acquistato oppure assegnato da un ente pubblico.
Rinnovo della locazione transitoria
Il rinnovo della locazione transitoria può avvenire tra le due parti solo se venisse confermata la transitorietà dell’alloggio e ciò deve avvenire tramite spedizione di raccomandata da inviare ovviamente prima della scadenza del contratto. Se viene dichiarato il falso, il proprietario è tenuto a risarcire tre mensilità del canone o in alternativa a ripristinare la vecchia tipologia di locazione.
Spese, cauzione e sconti fiscali
Il deposito cauzionale (massimo tre mesi di canone anticipato) avviene alla firma del contratto; sulla cauzione il proprietario dovrà versare ogni anno all'inquilino un interesse pari al tasso legale. Il canone d’affitto della locazione transitoria può essere libero oppure nei capoluoghi di provincia essere superiori al 20% rispetto alla formula del 3+2.
Per il proprietario, gli sconti fiscali sono il 15% del canone, da denunciare sulla dichiarazione dei redditi, mentre per l'inquilino, non è prevista nessuna agevolazione.
Le condizioni delle locazioni transitorie
Le locazioni transitorie presentano alcuni tratti distintivi rispetto alle altre tipologie di contratto. Il proprietario può far uso di questa locazione se deve vendere l’immobile in breve tempo, deve trasferire membri della sua famiglia nell’alloggio o deve fare lavori di edilizia. Le condizioni per una locazione transitoria per l’inquilino sono invece: possesso di un contratto lavorativo a tempo, impossibilità di alloggiare nella propria casa causa lavori di ristrutturazione, necessità di curare membri della famiglia in un immobile diverso dalla sua residenza o attesa per l’assegnazione della propria casa.
Altre tipologie di locazione
Esistono, oltre alla locazione transitoria, anche altri contratti per l’affitto di immobili come per esempio il contratto a canone libero 4+4, a canone concordato con la formula del 3+2 e i contratti di Locazione a studenti universitari. Si potrebbe aggiungere anche il subaffitto ma ciò è valido solo se non espressamente vietato nel contratto (anche se sul suo utilizzo ci sono da rispettare determinati vincoli) e comunque se presente ciò deve essere comunicato dall’inquilino.
Locazione a Roma

Quando ci si appresta a prendere una casa in affitto, è sempre importante valutare tante cose prima di effettuare la locazione definitiva. È bene in primis regolarizzare l'affitto stipulando un contratto firmato e registrato, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti futuri.
La registrazione del contratto dovrebbe infatti essere una cosa da fare in ogni situazione; molto spesso invece, soprattutto nei casi di affitti a studenti, questa pratica non viene presa assolutamente in considerazione. Il contratto di locazione è inoltre uno dei modi migliori per tutelare chi prende in affitto l'immobile stesso.
È inoltre poi indispensabile sapere che tipo di contratto si vuole stipulare; ci sono infatti diversi tipi di contratti di locazione: le locazioni agevolate, i contratti a carattere transitorio le sublocazioni, le locazioni commerciali, il comodato d’uso, ecc.
Nei casi di locazioni in grandi città come Roma, ad esempio, risulta spesso molto difficile effettuare la ricerca e trovare la casa in affitto nel luogo desiderato e che maggiormente si addice alle proprie esigenze. Con dei piccoli accorgimenti è però possibile trovare la locazione a Roma che fa al caso vostro.
A chi rivolgersi e come cercare
Per trovare una locazione a Roma, ci si può muovere in diversi modi. Si può andare in giro per la città, e nella zona interessata, a cercare i vari annunci affissi sui muri. In questi casi la locazione si effettua privatamente e quasi sempre, l'affitto viene effettuato in nero e senza stipula di un contratto.
La maggior parte degli annunci presenti per le strade di Roma, è infatti riferita a stanze da affittare a studenti e molto spesso sono direttamente dei ragazzi che vi abitano a subaffittare un posto letto. In ogni caso, per gli studenti che cercano una locazione a Roma, è possibile anche cercare sulle bacheche universitarie.
Per coloro che vogliono essere più sicuri e assicurarsi una locazione a Roma, regolare e con contratto, ci si può invece rivolgere presso le numerose agenzie immobiliari presenti e dislocate su tutto il territorio capitolino.
Infine è possibile trovare una casa in affitto a Roma acquistando i vari giornali specifici presenti in edicola, come il conosciutissimo Porta Portese.
Anche su Roma, come nel resto d'Italia, va infine sottolineato che dal 7 aprile 2011 l’Agenzia delle Entrate ha avviato il regime della Cedolare Secca sugli affitti, introducendo diverse agevolazioni in tal senso e novità molto interessanti.
Cessazione del contratto di locazione, quando e come
In un contratto ad uso abitativo, di solito si usa la formula del 4+4, ossia quattro anni più altri quattro rinnovabili. La cessazione avviene solitamente al termine del secondo rinnovo; tuttavia la legge prevede delle restrizioni per il proprietario se vuole disdire anticipatamente il contratto (es. cambio uso dell’immobile o trasferimento della famiglia nell’immobile stesso) mentre l’inquilino può recedere dal proprio affitto in qualsiasi momento, qualora ricorrano gravi motivi.
In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione, il proprietario deve comunicare la cessazione al Fisco versando l’imposta di registro pari a 67 euro tramite il modello F23; in questo modello vanno inseriti le generalità sia del locatore che del conduttore e il codice tributo. Negli altri casi, la cessazione del contratto di locazione deve essere comunicata entro sei mesi dalla data di scadenza nei contratti tradizionali mentre in quelli transitori possono bastare anche tre mesi.
La crisi degli affitti

Spesso però la cessazione del contratto di locazione avviene per i canoni d’affitto che diventano con il tempo insostenibili; è quello che sta succedendo a Savona, dove molti esercenti sono stati costretti ad abbassare la saracinesca per i costi troppo alti degli affitti. Affitti che vanno dagli 8000 ai 10000 mila euro che in questo periodo di crisi, con la contrazione del numero di clienti e il conseguente calo delle vendite, non riescono più ad essere assorbiti dai ricavi.
La Confesercenti di Savona in una lettera ha spiegato che il problema è più sociale che economico e che servirebbe l’adozione di un modello elastico che porterebbe una nuova concezione dell’affitto, legata da una parte a una quota fissa e dall’altra ai ricavi del negozio stesso. Conclude Confesercenti, per una modifica dell’intero apparato sul commercio, servirebbe una grande volontà di voler riformare queste regole che stanno strozzando l’economia e i negozianti.
La crisi degli affitti ha prodotto anzi un effetto contrario: secondo una recente indagine dell’AdnKronos, quasi la metà degli inquilini è in ritardo con il pagamento delle quote mensili al locatario e addirittura più del 20% non partecipa più alle spese di Condominio. La situazione più grave è al Sud con più del 60% dei cittadini che ha degli arretrati sulle quote da pagare mentre la Capitale Roma è poco sotto la media nazionale, 45%. Una vicenda molto complicata, visto che sullo sfondo c’è l’ipotesi sfratto con i locatari che però non sempre arrivano a questo passo, preferendo “trattare” con il conduttore in questione anche in virtù della lentezza degli sviluppi processuali in Italia. Eppure i dati del Ministero dell’Interno a riguardo sono diversi visto che la quasi totalità delle procedure per sfratto viene giustificata dalla morosità del conduttore. Il Governo Renzi ha stanziato un fondo per la morosità incolpevole (ossia determinata da cause di forza maggiore, come il licenziamento) ma le risorse purtroppo non sono bastate a debellare definitivamente il problema.
La crisi economica che si è scatenata in Italia e nel mondo dal 2008 in poi ha fatto sì che le case rimanessero invendute oppure che gli esercenti fossero costretti a chiudere bottega per affari che non decollavano. Sugli affitti il Governo Renzi nel 2014 ha voluto dare un incentivo attraverso agevolazioni fiscali concesse a chi compra casa e l’affitta ad un canone concordato per un periodo di otto anni. Agevolazioni che arrivano fino al 20% e che nelle intenzioni dell’esecutivo servono per rilanciare un settore stagnante. Le case infatti non vengono vendute, bloccando così gli imprenditori che non riescono a incassare nulla ma dall’altro lato i cittadini ancora non possono permettersi tali affitti per i costi elevati, che aggiunti al costo della vita quotidiana diventa insostenibile per chi guadagna circa 1000 euro al mese. E’ una situazione un po’ paradossale perchè si leggono notizie di affitti che crollano con agenti costretti a ri-trattare il prezzo ma dall’altra parte il calo dei prezzi non significa l’aumento delle richieste da parte dei cittadini. Forse bisognerebbe analizzare la situazione per zone specifiche perchè è difficile tracciare un quadro d’insieme, visto che nelle grandi città si è arrivati a costi alti nonostante i metri quadri di casa siano pochi.
Recesso del contratto da parte dell'inquilino
Prelazione all'acquisto dell'inquilino avviene solo se concessa contrattualmente; il rinnovo è invece automatico, salvo disdetta.
I prezzi più alti
Una ricerca condotta invece da Solo Affitti ha fatto luce sui prezzi delle stanze nelle principali città italiane. A Roma il costo arriva anche a 500 euro mensili nei quartieri a ridosso della Università principali (La Sapienza, Tor Vergata, Luiss o UniRoma 3). In generale il costo medio per una stanza singola nel Bel Paese si attesta intorno ai 300 euro mentre il posto letto in una stanza doppia comporta una spesa di 225 euro di media.
Tornando alle città italiane, detto dei prezzi altissimi di Roma, da citare anche la situazione di Milano con i suoi 450 euro di media; più basso il costo a Torino (350 euro). Anche le altre città più grandi d’Italia sono sopra la media nazionale, come Trento, Firenze, Napoli e Siena. Le città dove si risparmia di più sono Bari e Catania al Sud, dove non si spende più di 200 euro per una singola; la città con i prezzi più bassi è tuttavia Perugia con i suoi 150 euro. Il capoluogo umbro è meta di tanti studenti vista l’importanza delle scuole professionali e dell’Università presente.
Studenti fuori sede: perché conviene comprare casa
Poco prima dell’inizio della crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi anni si stava affermando, in Italia, una nuova tendenza che potrebbe tornare a crescere con la flessione dei prezzi della case: l’acquisto di appartamenti da parte di studenti fuori sede.
Nuovi scenari per i fuori sede
Nell’immaginario collettivo lo studente fuori sede vive in affitto, condividendo spazi e vita con giovani colleghi universitari o – negli ultimi anni fenomeno in crescita – con giovani precari fuori sede o in cerca della propria indipendenza dalle famiglie d origine. Non è sempre così. Sono in crescita, infatti, gli studenti convinti che investire nel mattone sia molto più conveniente che pagare anni e anni di affitto. Con il sostegno delle famiglie, soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano, si ritrovano ad accendere mutui, in alcuni casi più convenienti del pagamento mensile di un affitto.
Nelle metropoli, ad esempio, molto spesso il costo di una stanza singola è vicino alla rata di un mutuo, con l’inconveniente – pe gli amanti della privacy – della condivisione di spazi comuni. L’acquisto di un appartamento, nella maggior parte dei casi di un monolocale, è un’opportunità che colgono spesso le famiglie con più figli impegnati nello studio presso università lontane dalla città di nascita. Un’occasione da cogliere anche per chi ha intenzione di rimanere nella città adottiva, o più semplicemente un investimento che consente di risparmiare denaro e, in alcuni casi, di guadagnare.
È, ad esempio, quanto accade con l’acquisto di appartamenti più grandi rispetto ai monolocali le cui stanze vengono spesso affittate ad altri studenti, con regolari contratti, con positive ripercussioni sulle rate del mutuo e sui guadagni dello studente stesso.
Residenze universitarie, un miraggio
In Italia la scarsità di residenze universitarie, fenomeno che interessa tutte le città della Penisola, con picchi più o meno elevati, rende indispensabile per gli studenti interessati a frequentare corsi di laurea lontani da casa l’interesse per l’edilizia privata. Dati del Ministero della Ricerca e dell’Università, risalenti ad alcuni anni fa, parlano di circa appena 50.000 posti disponibili in residenze universitarie, a fronte del milione e 800 mila studenti iscritti preso le Facoltà italiane. Una copertura di appena il 2,7 per cento del totale, quota che colloca il Belpaese in fondo alle classifiche europee. Alcuni dati per un confronto diretto con i principali Paesi Ue: in Gran Bretagna i college servono uno studente su tre, coprendo il 29 per cento della popolazione universitaria. In Francia, invece, sono al 16 per cento, in Germania al 12, in Spagna all'8 per cento. Negli ultimi anni la situazione ha subito un lieve miglioramento, con l’inaugurazione di alcune residenze universitarie di nuova costruzione ma non basta per essere competitivi con il resto d’Europa.
Compro casa, dove?
Ecco quindi che si rende necessaria la scelta tra acquistare casa e affittarla. Per le famiglie che decidessero di ricorrere alla prima soluzione è bene tener presente alcuni aspetti fondamentali da valutare in fase di acquisto. La vicinanza al complesso universitario è una discriminante importante per chi si appresta ad acquistare un appartamento dove alloggiare nel corso degli anni di studi. Così come lo è la possibilità di avvalersi di una buona rete di servizi di trasporto pubblici, capaci di garantire tempestività e facilità di spostamenti.
Più vicino alla sede degli studi è l’appartamento più cresce il suo valore. Da tenere in conto, inoltre, l’importanza della prossimità di negozi di prima necessità, capaci di rispondere tempestivamente alle esigenze degli studenti. La fase di ricerca può, in più di un’occasione, portar via tempo prezioso da dedicare allo studio. Un modo rapido e sicuro per ottimizzare la ricerca e ridurre i tempi necessari a individuare l’immobile più adeguato al singolo studente è ricorrere al supporto del web, attraverso il ricorso a siti specializzati come Navacasa.it che garantisce la possibilità di visualizzare schede dettagliate relative agli appartamenti di interesse e vaste fotogallery.
FAQ
Quali sono le modalità per una risoluzione anticipata del contratto di locazione?
Per risolvere anticipatamente un contratto di locazione, è necessario rispettare le disposizioni previste dal contratto stesso e dalle leggi in materia. In genere, si può optare per la rescissione consensuale, ovvero un accordo tra il locatore e il conduttore per porre fine al contratto in modo anticipato, oppure per la risoluzione unilaterale, prevista dalle leggi solo in alcune circostanze (ad esempio, per gravi inadempienze da parte del locatore).
Quali sono le conseguenze di una risoluzione anticipata del contratto di locazione?
Le conseguenze della risoluzione anticipata del contratto di locazione dipendono dalle circostanze specifiche e dalle clausole del contratto. In genere, il conduttore potrebbe essere tenuto a pagare una penale o una quota di affitto corrispondente al periodo di preavviso, mentre il locatore potrebbe avere il diritto di trattenere la cauzione o chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. È importante consultare un esperto per valutare con precisione le conseguenze della risoluzione anticipata.
Posso chiedere una risoluzione anticipata del contratto di locazione
senza fornire una giustificazione?
In genere, la risoluzione anticipata del contratto di locazione richiede una giustificazione valida, come ad esempio il trasferimento per motivi di lavoro o la necessità di cambiare casa per motivi di salute. Tuttavia, alcune clausole del contratto potrebbero prevedere la possibilità di risolvere anticipatamente senza fornire una giustificazione, a patto di rispettare un periodo di preavviso e pagare eventuali penali. È importante verificare attentamente le clausole del proprio contratto prima di procedere alla risoluzione anticipata.
Se ti è piaciuto questo articolo, leggi anche la nostra guida sulla fideiussione per l’affitto e quello sulla disdetta di affitto.